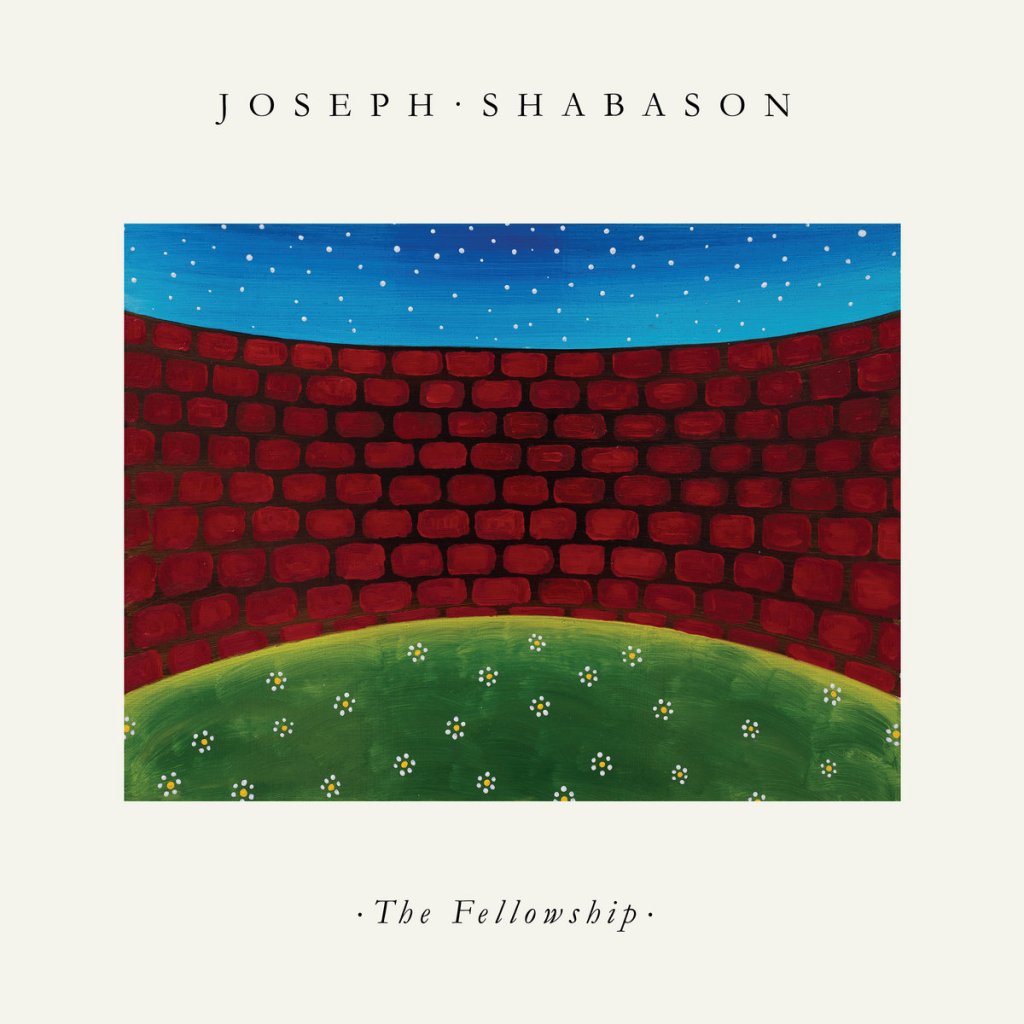
Quella di Joseph Shabason è probabilmente la migliore formazione culturale possibile per affrontare un tema come quello che regge The Fellowship: nipote di ebrei sopravvissuti all’Olocausto, figlio di figli di ebrei che hanno abbracciato la religione islamista. E The Fellowship è un vero e proprio saggio autobiografico che prende elementi biografici per cercare di raccontare due forme di spiritualità apparentemente in corto-circuito, ma che in realtà come capita sempre sono due diversi aspetti di un unico slancio verso la spiritualità.
Shabason non è nuovo a dischi che cercano di raccontare in musica un vissuto biografico, e già col precedente Aythce aveva cercato di musicare, per quanto possibile, gli orrori di una malattia degenerativa come il Parkinson e lo stesso ha fatto con Anne, espressamente dedicato alla malattia della madre. Su The Fellowship racconta se stesso e il suo rapporto con la religione, o le religioni, dovremmo dire, e lo fa forse in modo un po’ telefonato. Le otto tracce dell’album hanno titoli che cadenzano una narrazione, come capitoli di un ipotetico memoir che inizia con “Life with my Grandparents,” l’infanzia vera e propria, rappresentata piuttosto tautologicamente con registrazioni di una lallazione infantile, ma inserite in un contesto che subito richiama certo pop elettronico imbevuto di new-age, Sakamoto, se non i contributi strumentali di Fripp e Sylvian nel secondo lato di Gone to Earth.
Da qui il disco procede per saltelli, letteralmente: alla quiete quasi rappacificante dell’opening-track segue la tempesta di “Escape from North York,” un riff ossessivo di synth che innesca un fraseggio altrettanto ossessivo di vibrafono. Si ritorna subito alla quieta con la terza traccia, “The Fellowship,” per ripiombare subito in una dialettica tra quiete e tempesta, raziocino e tribalismo nella suite composta dal trittico “0-13,” “13-15” e “15-19,” con il passo intermedio, “13-15,” a rappresentare i primi vagiti dell’adolescenza, per poi riprendere quei tribalismi ancora selvatici dopo i sette minuti di calma di “15-19”(la sofferta conquista di una prima maturità) con la nevrotica “Comparative World Religions.”
È difficile raccontare una storia in musica, specie con un disco interamente strumentale, e l’espediente di prendere per mano chi ascolta e guidarlo mediante una segnaletica fornita dai titoli delle tracce potrà sembrare tanto utile quanto triviale, ma alla fine quella di Shabason è una partita vinta, e non solo è riuscito a far dialogare due mondi che lui stesso ha dovuto interiorizzare, ma anche a dare un nuovo senso a musica ormai invecchiata, da Sakamoto a Sylvian a Jon Hassel, che qui appare rigenerata con un nuovo approccio e nuovi suoni.