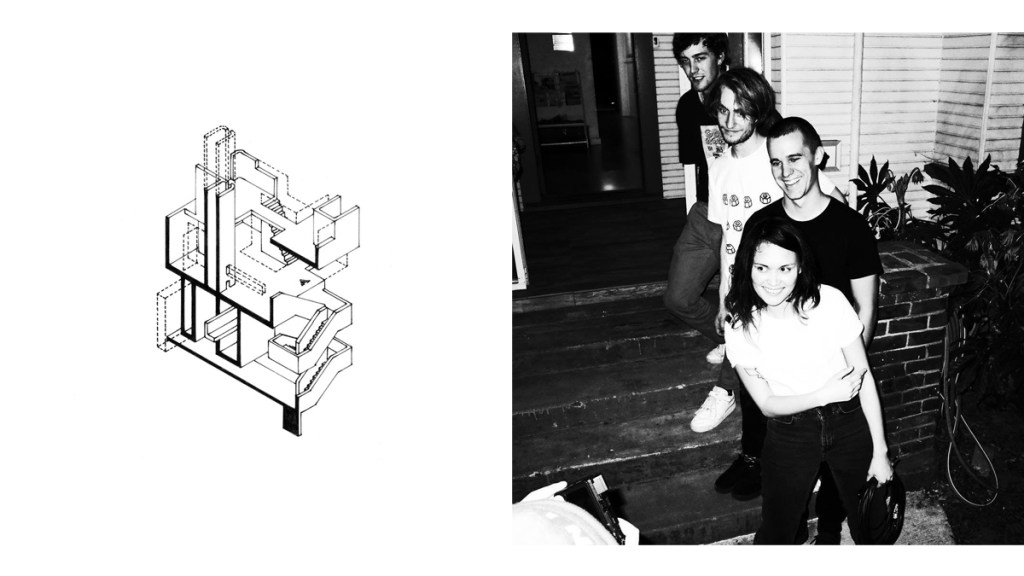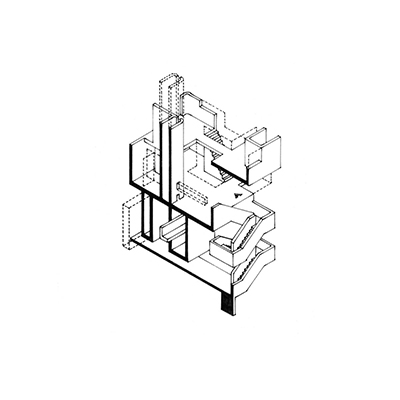
Con gli Sprain un po’ vince la nostalgia, e non solo perché sono stati se non scoperti almeno incoraggiati da Vern Rumsey degli Unwound, che li ha spinti a andare avanti. E gli Sprain avanti ci sono andati tornando indietro, a metà anni ’90, in quegli anni in cui il post-hardcore stava decidendo di trasformarsi in post-rock. Già nel primo Ep, Sprain, quando il gruppo era ancora un duo formato dal chitarrista e cantante Alex Kent e dalla bassista April Goffler si possono sentire le prime tendenze a uno slo-core dilatato. Era un ep registrato in casa, con una strumentazione essenziale e delle restrizioni sul volume, ma si sa, la necessità in mano a chi sa maneggiarla diventa virtù, e pezzi come “The Norwegian Black Metal” o “No One’s Home,” si avvicinavano alle dilatazioni dei Low, mentre in altre tracce si notavano già i toni esistenziali e dimessi di Alex Kent, quasi vicini a quelli di Robin Proper-Sheppard ai tempi dei God Machine.
Diventati un quartetto con gli innesti del chitarrista Alex Simmons e del batterista Max Pretzer gli Sprain di As Lost Through Collision hanno potuto dare sfogo a tutta la violenza che era rimasta inespressa e creare in questo modo una dinamica quasi estrema, un’escursione termica altissima tra quiete precaria e frastuono controllato che li mette al pari di maestri contemporanei del genere come i Pile. Gli Sprain fanno presto a diventare una delle band più richieste dell’area californiana, iniziano a aprire i concerti di band come Droswe, Planning for Burial e Elizabeth Colour Wheel e finiscono per entrare loro stessi nel vivaio The Flenser.
As Lost Through Collision è un disco angolare, ossuto, preciso come un meccanismo fatto di ingranaggi ben oliati, soprattutto nelle lunghe “Everything” e “Costant Hum,” forse i due pezzi in cui il gruppo funziona davvero come gruppo, come alchimia di quattro diversi elementi incastrati alla perfezione, fino a toccare code psichedeliche e noise. Geometria che è perfettamente resa dalla copertina disegnata dall’architetto Raymond Santana-Linares, il disegno di una sezione di un edificio in costruzione, immagine forse più adatta a un disco di musica elettronica, ma che rende bene l’idea del rock spigoloso degli Sprain, rock che riesce a essere anche fluido, come nella veloce e tirata “Worship House,”un pezzo degno dei Sonic Youth che amoreggiavano col neonato grunge, e a toccare dilatazioni slo-core in “My Way Out,” che inizia dimessa e remissiva e procede trascinandosi per sei minuti, fino a esplodere nella tempesta annunciata e attesa, forse prevedibile per chi è cresciuto con Rodan, June of ’44 e soprattutto i sacri Slint, band talmente chiamata in causa quando si trattava di descrivere la musica degli Sprain che Kent ha pensato di esorcizzare quel confronto con un gioco di parole nella taccia iniziale, “Slant,” e forse è proprio pensando a loro che ha scritto i versi “I’ll make you feel so small/and out of everyone you know/I’ll be the one you worship most.”
Santi e giganti del passato a parte, gli Sprain hanno l’onesta di non voler sacrificare la rabbia a una moda che tende a canonizzarla in territori indie modaioli, né accettano di scendere a compromessi con le orecchie delicate di chi gli può garantire un posto in vetrina. Un disco così venticinque anni fa sarebbe forse passato inosservato come uno dei tanti esempi di norma in atto. Oggi di un disco così forse c’era proprio bisogno.