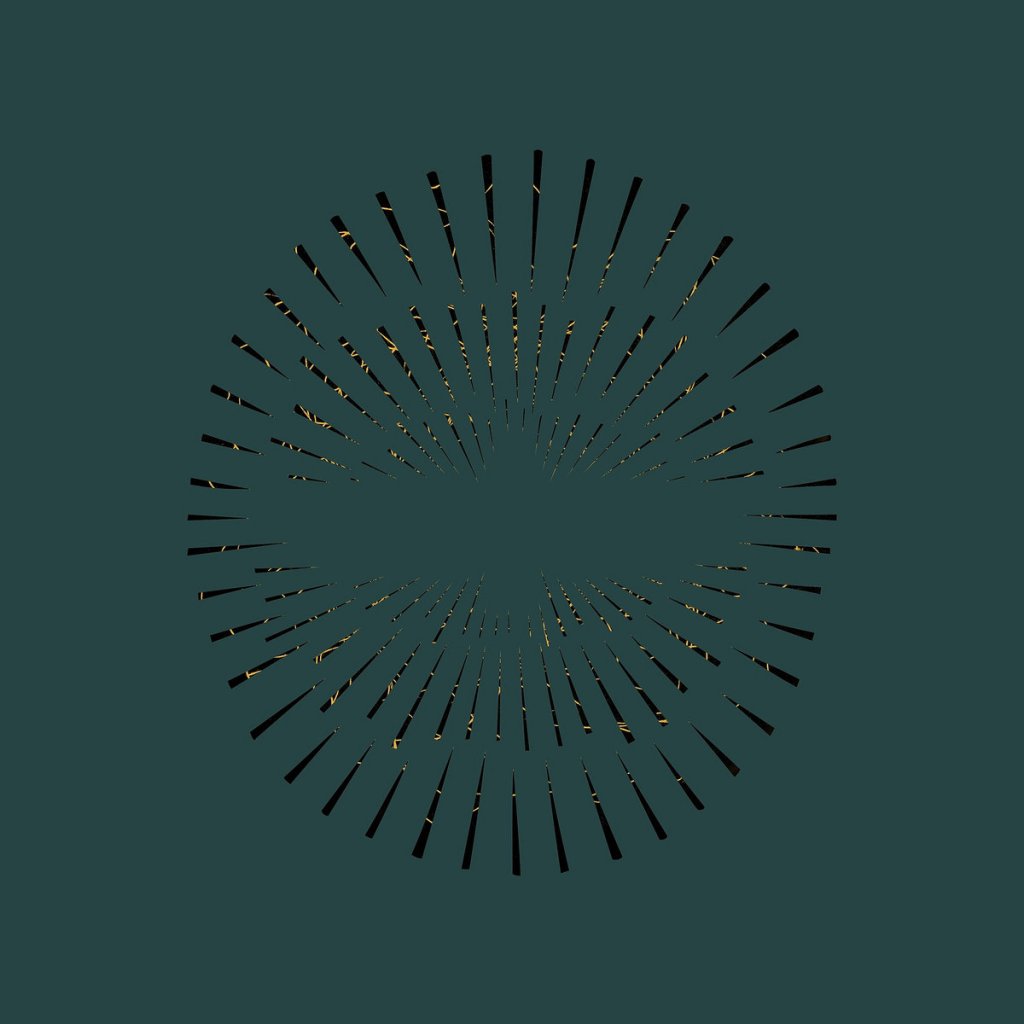
Appena prima che scoppiasse la pandemia con annessi lockdown e isterie collettive, Jasmine Guffond aveva realizzato il bellissimo Microphone Permission, un disco che raccontava l’era della sorveglianza virtuale cui siamo sottoposti per mezzo di quattro lunghe composizioni elettroniche. quel disco raccoglieva alcune idee che Jasmine Guffond già coccolava da tempo, tipo quella di trasformare i metadati di twitter in suoni, o creare una mappatura sonora del traffico di Sydney. Tra queste idee probabilmente ce n’erano anche alcune nate durante un progetto cui ha partecipato nel 2019, quando Monique Recknagel, proprietaria dell’etichetta Sonic Pieces, assemblò tre coppie di musicisti per farli suonare per il decimo anniversario dell’etichetta. Una di quelle collaborazioni fu proprio tra Jasmine Guffond e Erik Skovdin dei Deaf Center. Da quell’esperienza è nato The Burrow, registrato l’anno scorso a Berlino da Skovdin e Guffond con l’aiuto della vocalist finlandese Merja Kokkonen, che ha aggiunto alle parti sonore altre parti sonore vocali, fatte di glossolalia e suoni privi di un significato vero e proprio al di là del loro aspetto sonoro.
Nonostante sia stato pensato, suonato e registrato prima della pandemia, The Burrow sembra invece proprio raccontare l’anno inesistente che stiamo vivendo. E questo già dal titolo, ripreso dall’ultimo racconto di Kafka e che già da solo basterebbe a evocare quel senso di nido coatto che ci siamo cuciti addosso un po’ tutti: il rifugio di quel racconto è un rifugio fortificato che la creatura protagonista si costruisce attorno per difendersi da pericoli più pensati e immaginati che reali.
Per certi versi The Burrow è un disco costruito attorno al concetto di paura: la paura come meccanismo evolutivo che spingeva gli esseri viventi a agire e procedere con circospezione, e che proprio grazie a quella paura sono sopravvissuti. Le cinque composizioni che compongono The Burrow sono tutte intitolate a animali estinti o in via di estinzione, animali che non avevano o non hanno saputo usare quell’istinto primordiale che invece avrebbe dovuto salvarli. Così “Spilifer” nasconde dei sibili e droni dietro parche note di pianoforte, fino a esplodere in un lamento che può essere un richiamo di aiuto come un ultimo gemito in fin di vita. “White Eyes” nasconde una melodia lieve e fragile sotto dei clangori che possono essere rumori industriali, ossia i rumori dell’uomo che minaccia la natura, o più in generali l’incedere di un pericolo che ti spinge a rinchiuderti in una tana segreta.
Ascoltato oggi, quando una minaccia invisibile ci costringe in casa, quella tana assume un significato in più: è un rifugio, ma anche una prigione che ci vieta di vivere la nostra vita all’aperto, in comunione con gli altri, una fortezza che invece di rassicurarci ci rende ancora più spaventati. E quella prigione è fatta di suoni, di allarmi, suonerie, notifiche, rumori bianchi vari che minacciano di diventare l’unica testimonianza dell’esistenza di un fuori: mondo temporaneamente minaccioso che una paura amplificata ci costringe a guardare da uno schermo.
